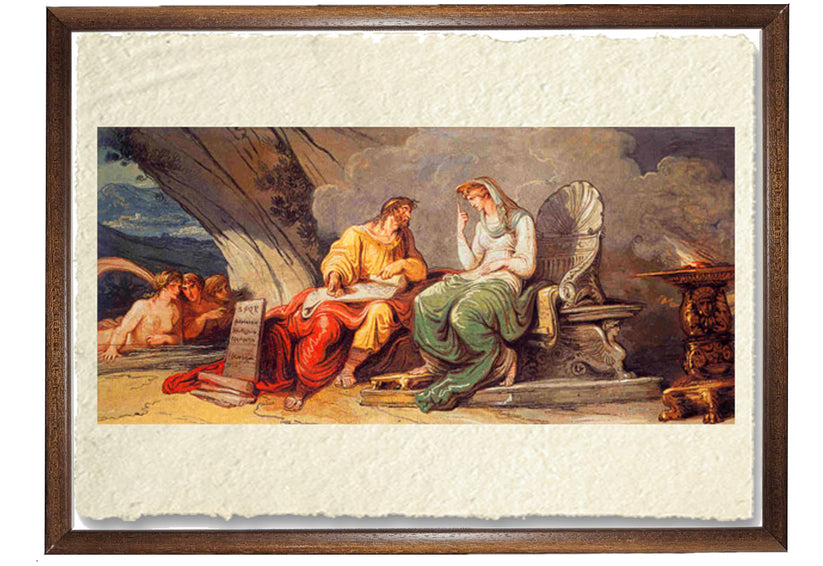Antinoo (110-130 d.C) fu un giovane della Bitinia, una antica provincia romana situata nell’odierna Asia minore, che intrecciò una relazione sentimentale e omosessuale con l’imperatore Publio Elio Adriano. Il ragazzo accompagnò l’imperatore durante i suoi viaggi attraverso le province orientali dell’impero, e alla sua tragica morte, avvenuta per annegamento nelle acque del Nilo, la sua figura venne divinizzata, raggiungendo per un certo periodo una popolarità simile a quella di Gesù.
La giovinezza di Antinoo e l’incontro con l’imperatore Adriano
Di Antinoo abbiamo poche informazioni: sappiamo che nacque nel 110 d.C, nella città di Claudiopolis, che si trovava in Bitinia, una provincia romana situata nell’Asia minore che corrisponde all’odierna Turchia nord-occidentale.
Molto probabilmente il ragazzo era di buona famiglia e di estrazione nobile: non abbiamo delle specifiche fonti che ce lo indicano in maniera inequivocabile, ma il fatto che abbia partecipato a degli eventi pubblici alla presenza dell’imperatore Adriano e che abbia avuto modo di interloquire con lui, lo colloca certamente presso una famiglia moderatamente agiata.

L’imperatore Adriano impiegò gran parte del suo tempo a viaggiare per tutto l’impero, e da innamorato dell’arte della cultura greca, nel 123 d.C era intento a visitare le zone orientali dei possedimenti romani.
Una delle tappe fondamentali del suo viaggio fu la città di Nicomedia, che l’imperatore scelse di visitare in quanto era stata appena colpita da una grave terremoto ed erano stati stanziati dei fondi per la ricostruzione delle principali infrastrutture e dei più importanti templi della zona.
Mentre supervisionava personalmente l’andamento dei lavori, durante un’occasione pubblica, l’imperatore incontrò probabilmente il giovane Antinoo.
Evidentemente in quella occasione l’imperatore si innamorò del ragazzo: la loro relazione, secondo la cultura romana, poteva essere accettata. La sessualità dei romani prevedeva la presenza di rapporti omosessuali senza particolari condanne. Quello che era veramente importante era che la persona dal maggiore rango sociale possedesse sessualmente il compagno di estrazione più bassa e non viceversa, affinchè non perdesse la sua virilità.
Adriano aggiunse così Antinoo al suo seguito e probabilmente gli fece frequentare una scuola di formazione nota come “Paedogogium“, dove i ragazzi imparavano la danza, il canto, e tutto quello che poteva far divertire l’imperatore durante la normale vita di corte.
Coloro che riuscivano a superare questa scuola, avevano il vantaggio di poter entrare in contatto, se non direttamente con l’imperatore, almeno con i membri più importanti dell’aristocrazia senatoria o in generale della nobiltà romana.
La convivenza tra Adriano e Antinoo
Dopo aver frequentato il suo corso di formazione, Antinoo divenne probabilmente un partner fisso di Adriano, tanto che alcune fonti ci informano che nel 125 d.C viveva stabilmente presso la villa dell’imperatore a Tivoli. L’abitazione di Adriano a Tivoli era assolutamente straordinaria: si trattava della ricostruzione, in scala minore, di tutti i luoghi che il regnante aveva visitato durante la vita. La villa era dotata di meravigliosi templi, di laghi artificiali, larghi boschi e costruzioni di finissima fattura.

Nel 127 d.C, Adriano era in viaggio in Italia e Antinoo molto probabilmente lo accompagnò. Nonostante l’età si facesse sentire e Adriano iniziasse ad accusare i sintomi di una malattia non meglio identificata, l’imperatore raggiunse nel 128 la Grecia e affrontò assieme al giovane amante una serie di iniziazioni religiose tipiche del mondo greco.
Dopodiché il viaggio dell’imperatore proseguì verso le province di Giudea e di Siria per poi arrivare in Egitto, dove i due presero dimora nell’agosto del 130 d.C
Il soggiorno di Adriano e Antinoo in Egitto fu particolarmente prolifico: sappiamo che i due andavano regolarmente a caccia insieme, che condividevano gran parte della giornata e che si lasciavano andare a divertimenti, anche lussuriosi.
Alcuni frammenti testimoniano come l’imperatore, in compagnia del ragazzo, avrebbe fatto visita sia alla tomba di Pompeo Magno, che proprio in Egitto era stato ucciso nel corso della guerra civile contro Giulio Cesare, sia al sarcofago di Alessandro Magno, che ai tempi rappresentava una visita obbligata per chiunque si recasse in Egitto.
Famosi sono le cacce ai leoni che Adriano e Antinoo facevano insieme: sembra addirittura che Adriano, in una occasione, abbia salvato la vita di Antinoo uccidendo un leone poco prima che questo caricasse il suo giovane compagno.
Dopodiché, Adriano e Antinoo decisero di prolungare il loro viaggio risalendo il fiume Nilo, come due veri innamorati.
La morte di Antinoo
Proprio in Egitto, la giovane vita di Antinoo conobbe fine. Sembra che nelle ultime settimane, Adriano si sia avvicinato alla pratica di alcuni riti magici. Forse il suo interesse era legato ai sintomi della sua malattia, e Adriano cercava un rimedio che potesse alleviare le sue sofferenze. Oppure, l’interesse dell’imperatore era rivolto alla questione più filosofica e religiosa che caratterizzava l’antica cultura egizia.
I due raggiunsero la città di Eliopoli, dove ebbero modo di visitare il famoso santuario di Thot e di prepararsi per celebrare la festa di Osiride. Esattamente il 22 ottobre del 130 d.C, mentre i due stavano festeggiando sul Nilo, il cadavere del giovane Antinoo venne ritrovato tra le acque del fiume.
Le fonti ci riferiscono che l’imperatore Adriano fu afflitto dalla fine del suo giovane amante, e sembrò dimostrare un accorato e sincero dolore.
La versione ufficiale riguardo la morte di Antinoo è quella di annegamento dovuta ad incidente. Sembra infatti che Antinoo, che era a bordo di una delle navi dell’imperatore, sia caduto accidentalmente nelle acque del Nilo e che non sia riuscito a guadagnare la riva.
Esistono però delle altre fonti antiche che propongono delle versioni alternative: la prima è quella di Dione Cassio, che oltre a citare la tesi dell’annegamento, parla di un possibile sacrificio. L’imperatore Adriano, probabilmente per essere liberato dalla sua malattia, avrebbe sacrificato la vita del giovane Antinoo come patto con gli Dei egizi.
In altre parole, il corpo del giovane sarebbe stato utilizzato per rendere efficaci gli incantesimi e le divinazioni che erano state fatte dai maghi egizi.

Anche un’altra fonte antica, in particolare Aurelio Vittore, scrive che aldilà della tesi dell’annegamento, i maghi avrebbero chiesto all’imperatore di sacrificare una vita che per lui fosse importante, e la scelta sarebbe ricaduta disgraziatamente sul ragazzo. Adriano avrebbe così prolungato la sua vita attraverso il sacrificio del giovane.
L’ultima fonte antica, la Historia Augusta, che a volte si lascia andare a dei pettegolezzi, sembra riassumere la presenza di diverse voci. Alcune parlavano dell’annegamento, altre del sacrificio per dei rituali magici, altre ancora di una eccessiva sensualità ed eccitazione di Adriano che sarebbe sfociata in tragedia.
Le interpretazioni sulla morte di Antinoo si sprecano, e la mancanza di dettagli sulla sua morte rendono questo, probabilmente, un mistero che non avrà mai definitiva soluzione. È anche possibile che Antinoo, più che essere una vittima sacrificale di Adriano, si sia offerto spontaneamente di sacrificare la propria vita per guarire il suo amato compagno.
La divinizzazione e il culto di Antinoo
Comunque sia andata la morte del giovane, Adriano attuò un processo di divinizzazione, per trasformare il suo sfortunato amante in un vero e proprio Dio. Adriano diede ordine di costruire una intera città a nome del ragazzo nota come Antinopolis, e che riprendeva, quanto a struttura urbanistica, i modelli classici delle città egizie.
Sembra che l’intenzione di Adriano fosse quella di seppellire Antinoo proprio nel centro della città a lui dedicata, ma per motivi non meglio identificati, scelse di riportare il feretro del ragazzo nella sua villa a Tivoli. Probabilmente non era ancora pronto per liberarsi della salma del giovane.
Adriano ordinò anche la costruzione di una importante quantità di statue che onoravano Antinoo come un Dio, con l’intenzione di sdoganare un vero e proprio culto del ragazzo. Antinoo venne collegato ai rituali della festa di Osiride e dall’Egitto il culto si diffuse abbastanza rapidamente in tutta la zona della Grecia, raggiungendo anche la città di Roma e le province dell’Africa settentrionale.

Il suo culto si espanse con particolare velocità: probabilmente la triste storia del ragazzo faceva facilmente presa nel cuore dei credenti, e soprattutto il fatto che un giovane mortale fosse elevato a Dio rendeva facile credere in una vita nell’aldilà.
Non sappiamo esattamente come si svolgevano i culti in onore di Antinoo, se venissero effettuati pellegrinaggi presso la sua tomba o la sua figura sia divenuta anche oggetto di divinazione secondo le più comuni pratiche orientali. Sappiamo però che la sua figura iniziò ad avere notevole successo, e che i credenti portavano regolarmente del cibo e si esprimevano in preghiere presso le oltre 2000 statue che vennero realizzate nel corso del tempo, e che i sacerdoti nei suoi templi onoravano il suo culto regolarmente.
Il culto di Antinoo, tuttavia, non riuscì ad attecchire e a fiorire nel lungo periodo: non conosciamo esattamente le motivazioni, probabilmente la sola spinta alla divinizzazione del ragazzo risiedeva nei provvedimenti ordinati da Adriano, i quali, dopo la sua morte, iniziarono ad ottenere un effetto via via sempre minore.
La figura di Antinoo gareggiò per un certo tempo con quella emergente di Gesù Cristo: il punto in comune fra i due è che entrambi erano stati degli uomini mortali, che con caratteristiche e attraverso storie diverse, erano ascesi al cielo diventando degli Dei.

La storia successiva, dall’Editto di Teodosio in poi, portò alla sistematica distruzione di tutti quei culti che potevano rappresentare un pericolo per il cristianesimo, e fu esattamente in quel periodo storico che le innumerevoli statue di Antinoo vennero abbattute.
La figura di Antinoo, non essendo riuscita a diventare un Dio del mondo antico, rimane ancora oggi estremamente affascinante, sia per la sua giovane età, sia come bandiera dell’amore omosessuale, e sia come storia, adatta ad esplorare le profondità dell’animo umano.